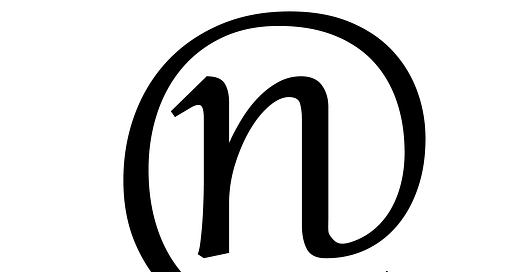Riflessioni su attivismi e linguaggi a margine dell'Assemblea generale di RENA
Il 4-5 maggio, i/le componenti dell'associazione RENA si sono incontrat* per preparare la Summer School 24. Fra i temi toccati, quello del linguaggio è centrale. Alcune riflessioni estemporanee.
Lo scorso weekend (4-5 maggio) si è tenuto a Forlì un incontro dell’associazione RENA: due giorni dedicati al kick-off del progetto Heroes - not just for one day e alla co-progettazione della Summer School 2024 (non sai di cosa si tratta? Dovresti: se stai leggendo queste righe, probabilmente sei un/a partecipante ideale). Il taglio che verrà dato quest’anno è ancora in discussione ma, in continuità con le ultime due edizioni, la RENA Summer 2024 si occuperà in qualche modo di attivismo e delle sfide che lo attraversano. Una delle più urgenti - almeno per quanto mi riguarda - ha a che fare con il linguaggio.
Il linguaggio come poiesis
Da sempre, i gruppi di persone che si riuniscono per cambiare l’ordine delle cose creano nuovi modi di comunicare, nuove parole d’ordine e nuovi concetti. Questo vale soprattutto per le comunità marginalizzate, i cui bisogni, esperienze e sfide raramente vengono rappresentati nel linguaggio ufficiale delle classi dominanti. Pensiamo ad esempio allo sforzo decennale dei movimenti femministi per rendere mainstream il termine femminicidio: imporre sulla scena pubblica un nuovo vocabolo significava rendere evidente un fenomeno che fino a quel momento era sottovalutato o invisibile - e quindi costringere la società a iniziare a farci i conti. Si tratta di una delle funzioni creative del linguaggio - la poesia nel suo significato greco originale ποίησις: “creare qualcosa che prima non c’era”.
Il linguaggio come strumento di aggregazione
Un nuovo linguaggio, inoltre, è anche un potente strumento per la creazione di in- e outgroup. All’interno dell’ingroup il nuovo vocabolario crea comunità e, quindi, rafforza il safe space: se parli come me, allora condividi con me un’identità e una visione del mondo, e con te mi sento al sicuro. Allo stesso modo, però - ed è inevitabile - il linguaggio crea anche l’outgroup, composto da coloro che non fanno uso di determinati strumenti. Alcune persone possono decidere di porsi nell’outgroup in protesta a ciò che un certo linguaggio sottende: ad esempio, se usare la schwa significa qualcosa, anche non usarla ha un significato altrettanto chiaro. In questi casi, più che parlare di in- e outgroup varrebbe la pena considerare due ingroups, divisi su un certo tema e che rimarcano questa differenza utilizzando codici diversi.
Il linguaggio come potenziale veicolo di esclusione
Non sempre, però, il mancato utilizzo di un certo codice linguistico (o l’utilizzo di uno inappropriato) è sintomo di un’adesione attiva a una determinata ideologia: come per tutti i linguaggi, molte persone semplicamente non li parlano, oppure li parlano male (ricordo ancora quando “di colore” era il termine politicamente corretto per rivolgersi alle persone razzializzate e “portatore di handicap” per le persone con disabilità). In questi casi, il linguaggio può essere un ostacolo alla comunicazione con l’outgroup senza intenzionalità da nessuna delle due parti ma con effetti comunque disastrosi.
Che fare? Semplificare il proprio linguaggio può sembrare una scelta allettante sul breve periodo, ma non è necessariamente un vantaggio: cedere al linguaggio mainstream rinunciando ad alcuni dei propri concetti chiave (magari però più incomprensibili o ostici) può sembrare un tradimento - se non dei propri valori, quantomeno della ricchezza dell’elaborazione. D’altra parte, utilizzare un linguaggio da ingroup al di fuori può avere risultati disastrosi - o ridicoli, come nel caso di un’operatrice sociale che, distribuendo pacchi alimentare durante la fase acuta del Covid a famiglie a basso reddito e spesso con background migratorio, avrebbe voluto presentarsi con i propri pronomi e chiedendo a beneficiari e beneficiarie di fare lo stesso.
Costruire un fronte comune senza un linguaggio comune?
L’attivismo di oggi si trova ad affrontare una stagione di policrisi che richiede un approccio sistemico e la costruzione di ampie coalizioni sociali. Questo sforzo passa anche da una riflessione sul linguaggio - o, per meglio dire, sui linguaggi, visto che diversi gruppi - le soggettività razzializzate e quelle genderizzate, le donne, le persone con disabilità ecc - stanno recuperando o elaborando una propria voce e costruendo vocabolari, immaginari, narrazioni per raccontare la propria versione del mondo. Questi gruppi hanno bisogno di capirsi e riconoscersi fra loro e di farlo con quella parte - maggioritaria - di outgroup che non è necessariamente e attivamente “dall’altra parte” ma che rischia di ritrovarcisi suo malgrado.
Da una parte, imporre il proprio linguaggio - composto di parole, elaborazioni, immaginario - è fondamentale per cambiare nel profondo la società e i suoi modelli.
Tornando all’esempio dei femminicidi: nominare il fenomeno è indispensabile per descriverlo e iniziare ad affrontarlo. E la condivisione di un linguaggio è uno degli elementi che caratterizza un safe space interno a una comunità.
D’altra parte, la costruzione di piattaforme con altre comunità e con l’outgroup è un obiettivo ormai irrinunciabile. Per molto tempo si è parlato della necessità di costruire un linguaggio comune fra diverse anime dell’attivismo - una soluzione comoda, ma che rischia per davvero di appiattire ed eliminare la complessità e la ricchezza delle elaborazioni portate avanti dai vari gruppi. A questa soluzione si contrappone un' altro concetto, credo più interessante: quello della traduzione.
Tradurre che significa letteralmente “portare dall’altra parte”. Che non vuol dire adattare - o appiattire - il proprio linguaggio, piegandolo ad un uso mainstream, quanto piuttosto saper parlare linguaggi diversi a seconda del contesto. Non rinunciare alla complessità che un termine specifico porta con sé, ma trovare il modo di esprimere la complessità dell’elaborazione andando oltre il vocabolario dell’ingroup.
Una sorta di multilinguismo delle voci, delle storie, degli approcci e dei vocabolari che le varie comunità di attivismo stanno elaborando e che hanno un disperato bisogno di mettere in connessione fra loro e con le vite e le esperienze di chi non si occupa attivamente di questi temi - ma può essere sensibile alle istanze. Il rischio alternativo è quello di andare a costituire ingroup isolati fra loro, ognuno con un proprio gergo incomunicabile all’esterno, sempre di più assediati dalla narrazione unica del potere.